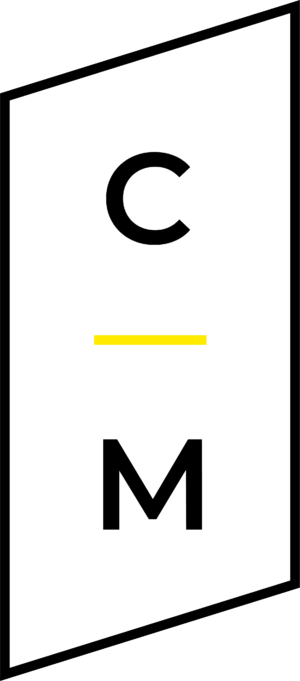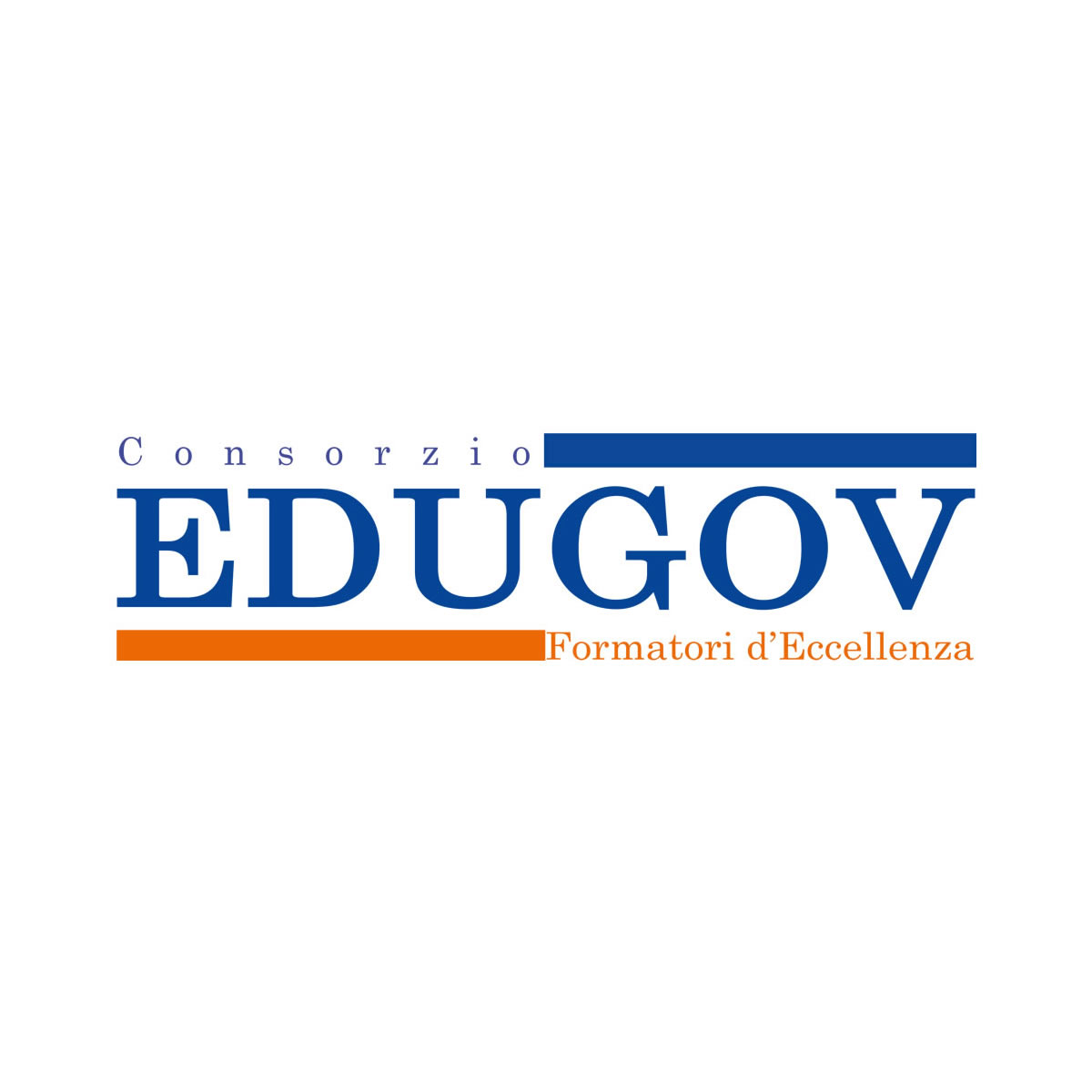Tac. Tac. Tac. Tre colpi secchi sul bordo della tazzina e il cucchiaino portato alle labbra, succhiato con lentezza, con indifferenza, i pensieri persi nel momento.
Alexander Patron beveva il suo caffè così da quasi vent’anni. Ritualistico senza esserne cosciente. Sensuale senza averne volontà.
Era come se fosse la vita a vivere lui e non il contrario, come se la sua mente mancasse totalmente d’intenzione, di attenzione. Le cose gli accadevano. Le “fortune” gli gravitavano attorno come corpi celesti con un buco nero, e nere diventavano pure loro. Lui lì, nel centro. Come quando ci si ferma sovrappensiero a guardare l’acqua mulinellare nello scarico del lavandino prima che scompaia. Ecco, era così che si sentiva. E questa cosa lo tormentava ormai da anni, gli dava ai nervi: cercava disperatamente di cambiare, di avere voce in capitolo e non ci riusciva. Non che se ne stesse lì, immobile, ad aspettare un risultato che non arrivava mai. Ma qualunque cosa facesse, nulla cambiava: era schiavo di se stesso, del suo volto, del suo corpo, dei suoi gesti.
Ecco: anche in quel momento si sentiva addosso gli sguardi languidi di almeno un paio dei clienti sparsi fra i tavolini di recupero di quel cafè boho chic di Lower Height. Boho chic. Che fastidio. Già si tendeva sulla sedia, in attesa di parare il colp. Gli pareva quasi di sentire il rumore degli ingranaggi nelle loro teste, persi nel languore della valutazione sull’abbordarlo o meno, su come farlo, su quante possibilità di successo avrebbero avuto, sul considerarlo materiale da marito o una storiella occasionale. Chissà a chi o a cosa stavano rubando l’attenzione per dedicarla a lui. Quel ticchettìo immaginario lo faceva impazzire. Li odiava, li odiava e odiava se stesso per la vanità sorda che nonostante tutto gli cresceva nel petto come uno xenomorfo, pronta a scoppiargli fuori e ucciderlo al primo segno di debolezza. Presto qualcuno si sarebbe mosso.
Negli ultimi dieci anni aveva provato in ogni modo ad annullarsi, a cancellare il fascino che gli era piombato addosso come una maledizione e non c’era riuscito. Mangiava poco e dormiva meno, tormentato dal senso di colpa per una storia di cui era stato a malapena comparsa. Si contorceva nel rimorso di scelte che non avrebbe comunque potuto compiere e che in ogni caso non avrebbero fatto alcuna differenza, si colpevolizzava nella speranza di infliggersi, lui, il dolore e strapparlo così dalle carni e dallo spirito della sua amica. Che da tempo per altro si era ormai allantonata, disgustata dal suo protagonismo involontario che la eclissava anche nella sofferenza, che non dava spazio a niente, neanche alle sue ferite, che le impediva di guarire, che la soffocava. Stephanie se n’era andata da almeno quattro anni, e forse anche per questo lui aveva deciso di trasferirsi a San Francisco, dove i reietti si accalcano per ricominciare.
Ma neanche quello era servito. Una città tanto attenta alle differenze da piallarle non era riuscita a rimanere indifferente, e pian piano i nuovi pezzi del puzzle avevano finito per formare la solita immagine.
Il rimorso gli aveva svuotato il corpo, ma gli occhi incavati e le unghie martoriate dai nervi anziché sottrarre avevano aggiunto, e ai suoi lineamenti regolari s’era unita un’aria decadente che tanto attirava gli sguardi delle crocerossine donne e uomini che popolavano la città, tutti pronti a proporsi d’aiutarlo, a volte in maniera anche troppo esplicita, quando in realtà volevano aiutare solo se stessi. E così il balletto era ricominciato, e la sua educazione cortese gli aveva impedito di scrollarsi di dosso con violenza quell’altruismo di facciata e di liberarsi da quella stretta che piano piano lo schiacciava. Per quanto si allontanasse sorridendo, loro spingevan per avvicinarsi, intrappolati e senza speranza come corpi nelle sabbie mobili. Sempre più pressanti, scivolavano giù e lui con loro.
Aveva provato, allora, a isolarsi nella lettura, nel tentativo vano di scomparire nei libri e dissolvere le sue ansie nelle storie altrui. E per un attimo aveva funzionato e aveva trovato sollievo nell’oblio, per un attimo aveva potuto cedere il posto sul palcoscenico a protagonisti di cui era impossibile rubare i riflettori, neanche a volerlo, perché anche su questo Stephanie aveva avuto ragione come al solito. Maledetta. Ma quell’attimo era durato poco: non c’è niente che attragga più l’attenzione di uno sguardo rapito da qualcosa, perché si vorrebbe che quegli occhi e quello sguardo fossero rivolti a noi e a noi soltanto. Alexander aveva così scoperto che ai lineamenti regolari e al fascino emaciato si era aggiunto lo charme dell’intellettuale, in una combinazione letale che richiamava alla mente sia citazioni pop sia di cultura alta, da Kurt Cobain ai protagonisti sofferenti di Baudelaire, rendendo la sua già troppo vasta platea ancora più ampia. Quante persone potevano esserci a San Francisco, possibile fossero quasi tutte attratte da lui? E più si poneva domande, più il cruccio lo torturava, più la distrazione e la stanchezza lo rendevano affascinante, in un ciclo apparentemente senza fine.
Era proprio per sfuggire a un ennesimo approccio non richiesto, garbato e viscido allo stesso tempo come solo certi uomini d’altri tempi sanno essere, che si era rifugiato in quel locale alla ricerca di un attimo di tregua. Aveva scelto un tavolino d’angolo, appartato e poco illuminato, neanche fosse un criminale costretto a cammuffarsi. Ma, ancora una volta, le sue azioni furono ininfluenti al risultato.
Tac. Tac. Tac. Tre colpi secchi sul bordo della tazzina, il cucchiaio portato lentamente alla bocca e il rumore di una sedia che si spostava.